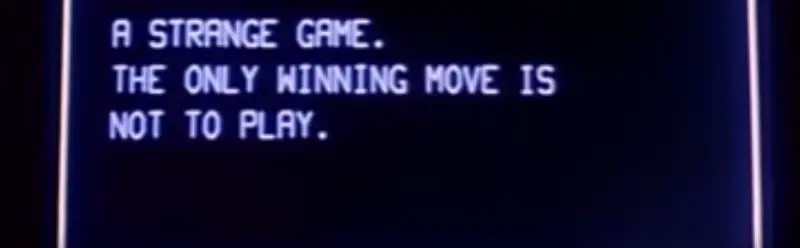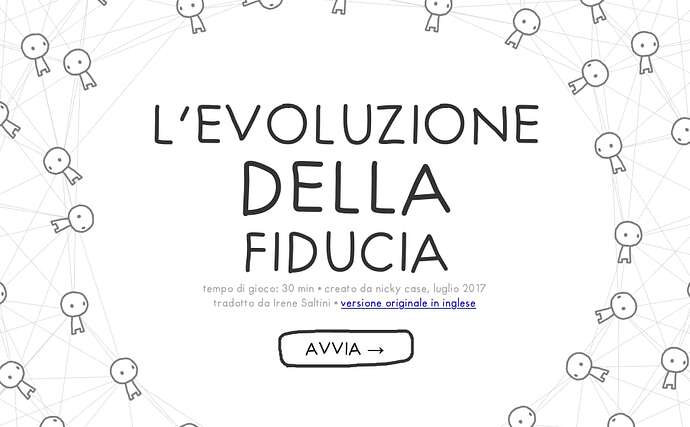Come i videogiochi e la teoria dei giochi influiscono sull’accettazione e addestramento alla guerra, ma potrebbero anche agevolare la comprensione e lo sviluppo della pace.
di Stefano Cecere
“Uno strano gioco. L’unica mossa vincente è non giocare.” (dal film WarGames)
- possono i giochi addestrare alla guerra?
- gli scacchi sono una buona rappresentazione di un conflitto? e il Go?
- cosa è il “complesso militare-entertainment” e come gli eserciti usano i videogiochi?
- l’Intelligenza Artificiale che impatto ha in tutto questo?
- possono le “strategie di guerra” essere usate per fini umanitari?
- esistono giochi per promuovere diritti umani, empatia e negoziazione?
Cercherò di dare qualche risposta che possa interessare in questo “mondo sull’orlo di una crisi di guerra”, soprattutto se guardiamo le nuove frontiere della tecnologia, dell’educazione, dell’etica e magari siamo cresciuti con i videogiochi o abbiamo figli che ne sono immersi.
Ho preparato questo breve trattato per l’intervento che ho presentato alla Fest8lina l’11 luglio che aveva come cardine una “costituente contro il sistema guerra” e mi sembrava interessante apportare punti di vista dal mio mondo di ricerca e sviluppo. Non è uno studio esaustivo ma penso che lo integrerò e migliorerò nel tempo e terrò aggiornati con la newsletter 2042 che ho iniziato anni fa proprio per parlare del presente per sopravvivere al futuro esplorando argomenti non convenzionali ma forse utili.
Introduzione
Un mondo in crisi
Il mondo sta vivendo crisi sempre più drammatiche e urgenti:
- cambiamento climatico
- conseguenti migrazioni e cambiamenti ecologici
- scarsità di risorse (anche per le nuove tecnologie)
- geopolitica internazionale conflittuale (Occidente VS BRICS)
- impennata tecnologica con disruption del mondo economico, lavorativo e sociale
- crisi demografiche
- estrema polarizzazione economica
Tutto ciò genera conflitti sempre più complessi, planetari, imprevedibili.
E bisogna prendere decisioni su cosa fare per risolverli.
Perché il Game Design
I giochi nella loro essenza sono sistemi interattivi governati da regole, vincoli e obiettivi, e quindi sono strumenti ideali per modellare e simulare sistemi umani complessi e le loro interazioni. Quando le interazioni portano a dei conflitti tra le parti si innescano dinamiche automatiche, dettate dal sistema, e intenzionali, guidate dalle scelte dei “giocatori”, che possono portare a diversi stati finali di vittoria, di perdita, di equilibrio.
Come vi si arriva, se con la guerra e vinca il più forte, o con la ricerca della pace e si cerchi di non perdere entrambi, dipende anche dalla nostra visione del mondo e da come siamo stati educati a gestire i conflitti. Conoscere la teoria dei giochi e la complessità dell’etica in campo può aiutare a superare la crisi in corso?
“Non tutte le guerre si combattono sul campo. Alcune si vincono con la comprensione.”
Complessità
Per comprendere meglio lo scenario contemporaneo e le tecnologie in gioco è bene accennare cosa si intende per complessità:
Il termine complessità si riferisce a una proprietà di sistemi o fenomeni caratterizzati da un alto grado di interconnessione, interdipendenza e dinamiche non lineari tra i loro elementi, rendendo il loro comportamento difficile da prevedere o comprendere pienamente. È un concetto usato in diversi ambiti, come scienze naturali, sociali, informatica e filosofia, e si distingue dalla semplice complicazione, che implica qualcosa di difficile ma prevedibile.
Un sistema complesso ha queste caratteristiche fondamenentali:
- non linearità, ovvero piccoli cambiamenti possono portare a effetti sproporzionati (es. effetto farfalla).
- emergenza (emergere), dove proprietà o comportamenti nuovi emergono dall’interazione delle parti, non prevedibili analizzando i singoli componenti (es. la coscienza dal funzionamento dei neuroni)
- adattabilità, ovvero questi sistemi si adattano al loro ambiente, come organismi viventi o società
- interdipendenza, dove le varie componenti sono fortemente collegate e un cambiamento in una parte influisce sul tutto
Motivazioni della guerra
Prima di proclamare “vogliamo la Pace” (non mettiamo in dubbio che la maggioranza delle persone la vogliano veramente), è fondamentale chiedersi due cose: perché scoppia una guerra? come voglio ottenere la Pace?
Superficialmente le guerre iniziano per dispute territoriali, differenze ideologiche o rottura di trattati.
Ma spesso le radici sono più profonde, le motivazioni reali sono un complesso intreccio di fattori politici, economici, ideologici e psicologici, quali:
- Potere e sicurezza: la preoccupazione fondamentale è la sopravvivenza dello Stato, l’affermazione dell’egemonia regionale o globale, l’indebolimento di un rivale, la creazione di Stati cuscinetto. La guerra diventa uno strumento per acquisire potere, garantire la propria sicurezza e mantenere o alterare l’equilibrio di potere globale. Questo può portare a un “dilemma della sicurezza”, in cui le azioni di uno Stato per aumentare la propria sicurezza (come un riarmo) vengono percepite come una minaccia da altri, innescando una spirale di sfiducia che può sfociare in un conflitto, anche quando nessuno lo desiderava inizialmente.
- Economia e risorse: storicamente la ricerca di territorio e risorse è stata una delle cause più comuni di conflitti. Una competizione per ottenere, conservare e accrescere risorse scarse come acqua, terra coltivabile, materiali rari o fonti energetiche, così come l’accesso a nuovi mercati e rotte commerciali strategiche.
- Ideologia e identità: la diffusione di un sistema politico o affermazione di un’identità nazionale o la difesa da una percepita minaccia culturale. Il nazionalismo, ad esempio, può unire un popolo ma anche alimentare xenofobia e aggressività verso l’esterno. Anche la religione è stata una potente motivazione, spingendo gruppi a giustificare la violenza in nome di una fede o della creazione di una società basata su determinati principi religiosi. Anche i conflitti etnici, spesso radicati in ingiustizie storiche o discriminazione, possono esplodere in guerre civili o internazionali.
- Conflitti interni: le disparità economiche e le crisi interne possono essere una motivazione a cercare conflitto esterni per distogliere l’attenzione e cambiare preoccupazioni e nemici.
- Fattori psicologici: la guerra può essere alimentata da desideri di ricchezza, status e potere. Anche una percezione errata delle intenzioni o delle capacità di un avversario può portare a calcoli sbagliati e a un’escalation involontaria. Inoltre, perché una guerra inizi, è necessario che almeno una delle parti abbia fiducia nella vittoria e la “volontà di entrare in conflitto”.
Prospettive e inevitabilità
Il generale prussiano Carl von Clausewitz definì la guerra come “la continuazione della politica con altri mezzi”.
Questa visione suggerisce che la guerra non è un’anomalia, ma uno strumento, seppur estremo, per raggiungere obiettivi che non si possono ottenere con la diplomazia. Se la pace è un delicato equilibrio tra molteplici forze, la guerra scoppia quando questo equilibrio viene a mancare.
La questione se la guerra sia inevitabile è al centro di un dibattito filosofico secolare.
Prospettiva realista
Secondo la scuola di pensiero realista nelle relazioni internazionali, il mondo è un sistema anarchico, privo di un’autorità superiore che possa imporre leggi, e la guerra è una caratteristica intrinseca e inevitabile del sistema internazionale. Data l’anarchia globale e la natura umana, il conflitto è sempre una possibilità e, a volte, una necessità per la sopravvivenza dello Stato.
Esempio fu la Guerra Fredda, con la corsa agli armamenti tra USA e URSS che agivano per mantenere o espandere la loro influenza, temendo la supremazia dell’altra parte.[1]
Possibili soluzioni alla guerra in questo scenario sono:
- Rafforzare la deterrenza (es. arsenali nucleari per la mutua distruzione assicurata)
- Creare alleanze per bilanciare il potere (es. NATO vs Patto di Varsavia)
- Accettare che la pace sia temporanea, basata su un equilibrio instabile
Il realismo è pessimista, sottovaluta il ruolo di istituzioni internazionali, cooperazione e valori condivisi. Può giustificare politiche aggressive come “inevitabili”.
Prospettiva liberale
La prospettiva liberale vede la guerra più come un incidente del sistema che come una sua “caratteristica” fondamentale, credendo che possa essere mitigata, e forse un giorno eliminata, attraverso la diffusione della democrazia (liberale, ovviamente), l’interdipendenza economica, norme condivise e la creazione di istituzioni internazionali che promuovono la cooperazione e il diritto. Gli Stati non sono gli unici attori: organizzazioni internazionali, ONG e individui giocano un ruolo importante.
La creazione dell’ONU e dell’UE (prima dell’attuale deriva bellicista) era vista come un successo liberale per prevenire guerre attraverso dialogo e integrazione economica.
Possibili soluzioni alla guerra in questo scenario sono:
- Rafforzare istituzioni internazionali (es. ONU, Corte Penale Internazionale)
- Promuovere il commercio e l’interdipendenza economica per rendere la guerra meno vantaggiosa (es. globalizzazione)
- Diffondere la democrazia e i diritti umani per ridurre le tensioni interne e internazionali
Il liberalismo è però considerato troppo ottimista, ignorando le dinamiche di potere e la difficoltà di cooperazione in un mondo di interessi contrastanti. Le istituzioni internazionali possono essere inefficaci se gli Stati potenti le ignorano o se vengono infiltrate da corrotti e lobbisti.
Il momento dell’inevitabilità
Il “momento” in cui la guerra diventa apparentemente inevitabile è spesso un punto di rottura, una drastica alterazione dell’equilibrio di potere o la disgregazione di una struttura di aspettative.
Qui entra in gioco la questione della fiducia nelle alternative, è una questione cruciale su cui ritorneremo.
Quando uno Stato sente che lo status quo è diventato ingiusto, insostenibile o che si è presentata un’opportunità irripetibile per cambiarlo, percependo che i costi del non agire superano i rischi del conflitto, può decidere di agire.
Un evento specifico, una crisi o una percezione di minaccia imminente possono agire da catalizzatore, rendendo il conflitto l’unica opzione percepita.
La Teoria dei Giochi
Se la cooperazione è spesso vantaggiosa, perché non la vediamo più spesso? La Teoria dei Giochi ci fornisce la risposta.
Il modo in cui i giochi definiscono l’obiettivo e la vittoria offre una metafora molto interessante per comprendere le diverse logiche della guerra.
La teoria dei giochi è una branca della matematica e dell’economia che analizza le interazioni strategiche tra più individui, chiamati “giocatori” con l’obiettivo di trovare la strategia migliore, ovvero quella che massimizza il proprio guadagno, tenendo conto delle possibili mosse degli altri e lo scenario, il campo, di gioco e le sue regole e interconnessioni.
L’idea di base è che, quando prendiamo una decisione, dobbiamo cercare di anticipare cosa faranno gli altri e come le loro azioni influenzeranno il nostro risultato. Non si tratta quindi di giochi come la tombola o le slot machine, dove conta solo la fortuna, ma di situazioni simili agli scacchi, al calcio o anche a molte decisioni economiche e sociali.
Gli elementi chiave sono:
- giocatori: sono i decisori coinvolti nell’interazione (persone, aziende, nazioni)
- strategie: sono le possibili azioni che ogni giocatore può intraprendere
- payoff (vincita): è il risultato o il guadagno che ogni giocatore ottiene a seconda della combinazione delle strategie scelte da tutti
Per i fini di questa introduzione, ci basta conoscere il meccanismo fondamentale della teoria dei giochi e la distinzione fondamentale tra giochi a somma zero e a somma non zero.
Il dilemma del prigioniero
E’ l’esempio più famoso per capire la teoria dei giochi. Immagina questa situazione: due complici di un crimine vengono arrestati e interrogati in stanze separate, senza possibilità di comunicare.
La polizia fa a entrambi la stessa offerta:
- se solo uno confessa (tradendo il complice), chi ha confessato viene liberato, mentre l’altro riceve una pena pesante (es. 7 anni)
- se entrambi confessano, vengono condannati entrambi a una pena media (es. 5 anni a testa)
- se nessuno dei due confessa, verranno condannati per un reato minore, con una pena leggera per entrambi (es. 1 anno a testa)
Cosa conviene fare?
Analizzando la situazione dal punto di vista del singolo prigioniero, la logica suggerisce di confessare. Perché
- se il mio complice non confessa, a me conviene confessare per essere libero invece di fare 1 anno
- se il mio complice confessa, a me conviene comunque confessare per fare 5 anni invece di 7
Quindi, per entrambi, la scelta più “razionale” a livello individuale è confessare. Il risultato, però, è che entrambi si prendono 5 anni. Se avessero potuto fidarsi l’uno dell’altro e non avessero confessato, avrebbero preso solo 1 anno a testa, ottenendo un risultato complessivamente migliore.
Questo dilemma dimostra come la ricerca del massimo vantaggio individuale possa portare a un risultato peggiore per tutti i partecipanti. Ma diamo per scontato che tutti i giocatori siano razionali e non mossi da emozioni.
Giochi a Somma Zero: se io vinco, tu perdi
In un gioco a somma zero, il guadagno di un giocatore corrisponde esattamente alla perdita di un altro. Le risorse in gioco sono fisse e non possono aumentare né diminuire. È una situazione puramente competitiva.
Pensiamo a una fetta di torta: se io ne prendo un pezzo più grande, a te ne rimarrà per forza uno più piccolo. La somma dei guadagni e delle perdite è sempre zero.
Il gioco degli scacchi è l’esempio classico. L’obiettivo non è negoziabile: è lo scacco matto, la neutralizzazione completa del Re avversario con un vincitore e un perdente. La vittoria di uno è la sconfitta dell’altro (+1 per il vincitore, -1 per lo sconfitto = 0).
Anche giochi come il poker sono a somma zero (con più giocatori): i soldi vinti da un giocatore sono esattamente i soldi persi dagli altri. Il totale sul tavolo non cambia, si sposta solo da un giocatore all’altro.
Caratteristica chiave: mentalità “mors tua, vita mea” (morte tua, vita mia). Non c’è spazio per la cooperazione.
Giochi a Somma Non Zero: possiamo vincere (o perdere) entrambi
In un gioco a somma non zero, i guadagni e le perdite dei giocatori non si annullano a vicenda. Il risultato finale può essere un guadagno netto o una perdita netta per tutti i partecipanti. Questo permette sia la cooperazione che la competizione.
La torta può diventare più grande se si collabora, oppure può andare a male per tutti se non ci si accorda.
Un esempio è il commercio tra due aziende: se un’azienda di software e una di hardware collaborano, possono creare un prodotto migliore che fa guadagnare entrambe. Il mercato totale cresce. Entrambe vincono.
Come abbiamo visto nel Dilemma del Prigioniero se entrambi i prigionieri collaborano (non confessando), ottengono entrambi un risultato migliore (1 anno di carcere a testa) rispetto a quando si tradiscono a vicenda (5 anni a testa). La collaborazione crea un vantaggio comune.
Caratteristica chiave: Il risultato non è fisso e le decisioni dei giocatori possono aumentare o diminuire il valore totale in gioco. È possibile (ma non garantito) che tutti i partecipanti traggano un beneficio.
Politica e teoria dei giochi
Molti leader politici operano secondo una logica a somma zero: la mia vittoria è la tua sconfitta. L’obiettivo non è trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa, ma massimizzare il proprio guadagno a discapito dell’avversario.
Tuttavia, la Teoria dei Giochi dimostra anche che le strategie puramente competitive portano spesso a risultati sub-ottimali per tutti. La soluzione migliore deriverebbe da una logica win-win, basata sulla cooperazione e sulla fiducia. La guerra diventa inevitabile quando la fiducia crolla a tal punto che la cooperazione è vista come un rischio inaccettabile e la competizione aggressiva come l’unica via per la sopravvivenza o il dominio. I giochi sono un campo di addestramento perfetto sia per la mentalità a somma zero che per esplorare alternative collaborative.
Giochi e modalità di vittoria nelle guerre
Il modo in cui i giochi definiscono l’obiettivo e la vittoria offre una metafora potente per comprendere le diverse logiche della guerra.
-
Giochi a Somma Zero (vincere = annientare): Il gioco degli Scacchi è l’esempio classico. Questo rispecchia le guerre totali, dove la vittoria significa la distruzione dell’esercito nemico, la conquista della capitale o il rovesciamento del regime. La vittoria è assoluta e la perdita dell’avversario è la propria condizione di vittoria. Molti giochi e videogiochi di guerra semplificano il conflitto in una logica simile, dove “vincere” significa eliminare tutti i nemici e completare la missione.
-
Giochi di posizione e influenza (vincere = prevalere): Il gioco del Go offre un modello diverso. L’obiettivo non è catturare un pezzo specifico, ma controllare più territorio dell’avversario. La vittoria è relativa e si costruisce mossa dopo mossa, accumulando un vantaggio strategico. Questo modello si adatta a conflitti prolungati, guerre di logoramento o competizioni geopolitiche a lungo termine, dove l’obiettivo non è la distruzione, ma il raggiungimento di una posizione di predominio.
-
Giochi di Pace (vincere = risolvere) I “serious games” per la pace ridefiniscono completamente il concetto di vittoria. In un gioco come This War of Mine, “vincere” significa semplicemente sopravvivere fino al cessate il fuoco, spesso a costo di terribili compromessi morali. In PeaceMaker, la vittoria è il raggiungimento di una soluzione a due Stati nel conflitto israele-palestina. L’obiettivo del World Peace Game è esplicitamente quello di raggiungere la prosperità globale con il minor intervento militare possibile. In questi giochi, la vittoria non è sconfiggere un nemico, ma risolvere il problema alla radice del conflitto.
Prospettive storiche e giochi
Riferendoci alle due prospettive accennate prima, possiamo ora collegare
- nel realismo, la guerra è spesso modellata come un gioco a somma zero dove ogni Stato cerca di massimizzare il proprio potere a scapito degli altri. La deterrenza nucleare è un esempio di equilibrio di Nash, dove nessuna parte attacca per paura delle conseguenze.
- nel liberalismo, i giochi cooperativi prevalgono: gli Stati possono raggiungere esiti positivi per tutti (es. trattati di pace, accordi commerciali) attraverso negoziati e fiducia reciproca, riducendo l’incentivo alla guerra.
Perché non è sempre una win-win?
Una soluzione “win-win” è, in teoria, spesso la più razionale dal punto di vista collettivo.
Ma nello scenario del Dilemma del Prigioniero i due attori, agendo in modo perfettamente razionale per massimizzare il proprio interesse individuale, finiscono per tradirsi a vicenda, ottenendo un risultato peggiore per entrambi rispetto a quello che avrebbero ottenuto cooperando. Questo accade a causa della mancanza di fiducia e della paura di essere sfruttati dall’altro.
Le relazioni internazionali spesso assomigliano a un Dilemma del Prigioniero su vasta scala.
Anche se il disarmo reciproco sarebbe vantaggioso per due nazioni rivali (risparmiando immense risorse), la paura che l’altro possa armarsi segretamente spinge entrambe a continuare una costosa e pericolosa corsa agli armamenti.
La scelta “razionale” a livello individuale (armarsi per non essere vulnerabili) porta a un risultato “irrazionale” e sub-ottimale a livello collettivo.
La teoria dei giochi, tuttavia, non è solo pessimista. Mostra anche le condizioni necessarie per superare questo dilemma: interazioni ripetute, la possibilità di costruire fiducia, la reputazione e la creazione di istituzioni e norme che facilitino e garantiscano la cooperazione.
In sostanza, la teoria dei giochi non dice che la soluzione “win-win” è impossibile, ma spiega perché è così difficile da raggiungere in un ambiente di anarchia e sfiducia, e quali strumenti (diplomazia, trattati, organizzazioni internazionali, informazione perfetta) sono necessari per costruirla.
Giochi per la guerra
I progenitori della strategia: giochi antichi e filosofia militare
Molto prima dell’avvento delle simulazioni militari contemporanee, i giochi da tavolo astratti costituivano il mezzo principale per esplorare i principi del conflitto e della strategia. Gli antichi giochi degli scacchi e del Go, in particolare, rappresentano due filosofie di guerra distinte e durature che continuano a risuonare nella dottrina militare moderna.
Gli scacchi, che hanno origine dal gioco indiano Chaturanga (che significa “quattro divisioni dell’esercito”), sono un analogo diretto di una battaglia decisiva. L’obiettivo del gioco è la sconfitta inequivocabile dell’avversario attraverso lo “scacco matto” del suo Re. Ciò rispecchia la filosofia militare occidentale, fortemente influenzata da pensatori come Carl von Clausewitz, che enfatizza l’identificazione e la distruzione del “centro di gravità” del nemico, che sia il suo esercito principale, la sua capitale o la sua leadership, per ottenere una vittoria rapida e totale. I pezzi del gioco sono gerarchici e specializzati, ciascuno con movimenti e poteri unici, che riflettono i diversi ruoli della fanteria, della cavalleria e delle altre unità in una forza armata combinata.
Questo design promuove intrinsecamente una mentalità incentrata sul combattimento diretto, l’attrito e lo scontro culminante che decide l’esito del conflitto.
In netto contrasto l’antico gioco cinese del Go (o Wei-Qi, che significa “gioco dell’accerchiamento”) non modella una singola battaglia, ma la totalità di una guerra. Nel Go, tutti i pezzi sono identici e l’obiettivo non è quello di distruggere un singolo pezzo chiave, ma di circondare gradualmente e conquistare più territorio dell’avversario, vincendo con un accumulo di punti. Ciò riflette una filosofia strategica basata sulla pazienza, sugli approcci indiretti e sull’accumulo di influenza a lungo termine, una mentalità famosa per essere stata articolata dall’antico stratega Sun Tzu e spesso associata al pensiero strategico cinese moderno. Il gioco insegna il valore dell’accerchiamento strategico, della flessibilità e della comprensione che una singola perdita in un’area del campo di gioco non significa la perdita dell’intera guerra.
La differenza fondamentale tra questi due giochi - l’annientamento di un re contro l’accumulo di territorio - va oltre le regole: riflette e rafforza approcci culturali fondamentalmente diversi al conflitto.
La preferenza per un tipo gioco particolare può rivelare la cultura strategica sottostante di un’istituzione o di un popolo.
L’attenzione storica delle forze armate occidentali alla “battaglia decisiva” è un discendente intellettuale del paradigma degli scacchi, dove la strategia è orientata a forzare un unico scontro conclusivo.
Questi giochi antichi, pur non essendo strumenti di addestramento diretto, hanno stabilito il precedente fondamentale di concettualizzare la guerra come un sistema basato su regole, gettando così le basi cognitive e culturali per lo sviluppo di giochi di guerra formali e professionali.
La rivoluzione prussiana: la nascita del Kriegsspiel
Il momento cruciale in cui i giochi di guerra passarono da passatempo aristocratico a strumento militare indispensabile avvenne nella Prussia dell’inizio del XIX secolo. Questa rivoluzione fu guidata da una ricerca incessante del realismo, dal desiderio di creare una simulazione così fedele alle condizioni del campo di battaglia da poter servire come vero e proprio “addestramento alla guerra”.
I primi tentativi, come il gioco sviluppato da Johann Hellwig nel 1780, erano innovativi per l’epoca, introducendo quadrati codificati in base al terreno e pezzi che rappresentavano unità militari. Tuttavia, rimanevano fondamentalmente limitati dalla loro griglia simile a quella degli scacchi e dalle regole astratte, che non riuscivano a catturare la natura fluida e caotica del combattimento reale.
La vera svolta arrivò dal barone von Reisswitz e da suo figlio, il tenente Georg Heinrich von Reisswitz. La loro creazione, presentata ufficialmente allo Stato Maggiore prussiano nel 1824, fu chiamata Kriegsspiel, letteralmente “gioco di guerra”.
La genialità del Kriegsspiel risiedeva in una serie di innovazioni rivoluzionarie che sostituivano sistematicamente le astrazioni dei giochi precedenti con approssimazioni della realtà:
- verosimiglianza e mappe topografiche: il passo più significativo fu l’abbandono delle griglie a favore di mappe topografiche militari reali, disegnate in scala precisa 1:8000. Ciò consentiva di simulare conflitti in luoghi reali e costringeva gli ufficiali a confrontarsi con le sfide tattiche reali poste dalle caratteristiche del terreno, come foreste, fiumi e colline.
- l’arbitro e la nebbia di guerra (fog of war): Kriegsspiel introdusse un arbitro neutrale, un ruolo essenziale per la sua funzione di strumento di addestramento. L’arbitro faceva rispettare le regole, giudicava l’esito dei combattimenti utilizzando dadi e tabelle di probabilità dettagliate e, cosa più importante, gestiva il flusso di informazioni. Tenendo nascoste all’altra parte le mappe e i pezzi di ciascuna fazione, l’arbitro creava la “nebbia di guerra”, costringendo i giocatori a prendere decisioni basate su informazioni incomplete e imperfette, proprio come deve fare un vero comandante. Questo eliminava la “visione divina” (a informazione perfetta, direbbero i teorici dei giochi) dei giochi precedenti e introduceva l’elemento cruciale dell’incertezza e imprevedibilità.
- meccaniche realistiche e risultati basati sui dati: le regole del gioco non erano arbitrarie e i movimenti venivano misurati con righelli e i risultati dei combattimenti erano determinati dal lancio di dadi incrociati con tabelle dettagliate derivate dai dati empirici raccolti dall’esercito prussiano durante le guerre napoleoniche. Queste tabelle tenevano conto del tipo di unità, della portata, del terreno e persino del morale e della stanchezza. Per la prima volta, le unità potevano subire perdite parziali, un concetto che i giocatori moderni riconoscerebbero come “punti ferita”, invece di essere semplicemente rimosse dal tabellone.
L’adozione del Kriegsspiel da parte dell’esercito prussiano fu notoriamente catalizzata dal capo di Stato Maggiore Von Muffling, che, dopo aver assistito a una partita, esclamò: “Questo non è un gioco! È un addestramento alla guerra! Devo raccomandarlo a tutto l’esercito”.
Il suo sostegno portò alla sua istituzionalizzazione all’interno del corpo degli ufficiali prussiani. Dopo la sorprendente vittoria della Prussia sulla Francia nella guerra franco-prussiana del 1870-71, altre nazioni si affrettarono ad adottare il Kriegsspiel, considerandolo il segreto del successo militare prussiano. Ciò consolidò il ruolo del wargaming come strumento fondamentale per l’addestramento, la pianificazione operativa e lo sviluppo della dottrina nelle forze armate moderne di tutto il mondo.
Tuttavia, questa adozione non fu priva di attriti. L’idea stessa di “giocare” alla guerra fu accolta con scetticismo e gelosia professionale, una resistenza culturale che contribuì tragicamente al suicidio del suo inventore, il giovane Reisswitz.
Ciò evidenzia rivela un disagio culturale e un’ansia istituzionale nell’associare la gravità della guerra alla frivolezza percepita del gioco, con l’occasionale evitamento da parte dei militari di usare il termine “wargame” e la segretezza storica riguardo al loro uso per paura della percezione pubblica
Digitalizzazione dei conflitti contemporanei
I principi stabiliti dal Kriegsspiel - realismo, fog of war e risultati basati sui dati - costituirono le fondamenta della simulazione militare per il secolo successivo. L’avvento della tecnologia digitale nella seconda metà del XX secolo non sostituì questi principi, ma li amplificò, consentendo simulazioni su scala, velocità e complessità molto maggiori.
Durante i principali conflitti del XX secolo, il wargaming è stato uno strumento essenziale per la pianificazione strategica. Lo Stato Maggiore tedesco lo ha utilizzato per sviluppare e perfezionare le tattiche della Blitzkrieg prima della seconda guerra mondiale, mentre sia gli Stati Uniti che il Giappone hanno fatto ampio uso del wargaming per pianificare importanti operazioni navali nel Pacifico, compreso l’attacco a Pearl Harbor. Durante la guerra fredda, l’ambito dei giochi di guerra si è ampliato fino a comprendere scenari nucleari e complesse considerazioni politiche.
Il complesso militare-entertainment
Aneddoto: nel 2015 il Dipartimento della Difesa USA (amministrazione Obama) assegnava 525 milioni al Pentagono per sviluppare progetti di wargames da integrare nel loro reparto di analisi e simulazione.
Il dopoguerra ha visto anche la nascita di un solido hobby commerciale legato al wargaming. Aziende come Avalon Hill, fondata da un ex progettista della RAND Corporation, hanno tradotto le complesse simulazioni militari in giochi da tavolo per un pubblico civile. Ciò ha dato vita a una vasta sottocultura di appassionati esperti di concetti come griglie esagonali, tabelle dei risultati di combattimento e segnalini. Questa cultura hobbistica, a sua volta, ha alimentato la fiorente industria dell’intrattenimento elettronico. Le origini stesse dei videogiochi sono profondamente legate al nesso tra ricerca militare e accademica che ha alimentato i primi progressi dell’informatica durante la seconda guerra mondiale.
La convergenza degli interessi militari e dell’industria dei videogiochi commerciali ha dato vita a un fenomeno potente e controverso: il complesso militare-entertainment. Questa relazione simbiotica (in cui entrambe le parti traggono notevoli vantaggi) sfrutta l’immenso potere culturale ed economico dei videogiochi per servire gli obiettivi strategici dello Stato, principalmente nei settori delle pubbliche relazioni, del reclutamento e della formazione dell’opinione pubblica sulla natura della guerra.
Consenso e reclutamento
Nella relazione con l’industria videoludica l’esercito ottiene un potente canale per plasmare la propria immagine pubblica. Fornendo agli sviluppatori di giochi l’accesso alle basi militari, alle competenze tecniche, al personale in servizio attivo e alle attrezzature hi-tech, garantisce che la sua rappresentazione in questi media popolari sia prevalentemente positiva, eroica ed emozionante. Ciò costituisce una forma altamente efficace di pubbliche relazioni e un potente strumento di reclutamento.
In cambio, gli sviluppatori di videogiochi ottengono una parvenza di autenticità e realismo, che sono risorse di marketing inestimabili in un mercato dell’intrattenimento competitivo.
I teorici critici sostengono che questa collaborazione porta alla produzione di uno “spettacolo di violenza”, in cui la guerra viene mercificata e trasformata in un prodotto di intrattenimento consumabile e persino piacevole. Questo spettacolo non è neutro; è amplificato attraverso connessioni intertestuali con altre forme di media, come i film di guerra, ed è reso profondamente persuasivo dalla natura immersiva e interattiva che incoraggia i giocatori ad adottare la visione del mondo presentata dal gioco.
Negli ultimi anni, la strategia di reclutamento dell’esercito si è evoluta oltre la semplice collaborazione su titoli commerciali. Di fronte alla carenza di reclute, corpi come l’esercito, la marina e l’aeronautica degli Stati Uniti hanno istituito squadre di eSport ufficiali. Queste squadre impiegano personale in servizio attivo per trasmettere in streaming giochi popolari su piattaforme come Twitch e YouTube, interagendo direttamente con un pubblico giovane e esperto di tecnologia in modo informale e accessibile.
Questa strategia rappresenta un passaggio dall’utilizzo del gioco stesso come attrazione principale all’utilizzo del “giocatore-reclutatore” come punto di connessione, con l’obiettivo di rendere l’esercito più accessibile e colmare il “divario con la società” cercando di creare consenso e interesse per il servizio militare fin dalla giovane età.
Caso studio: America’s Army
America’s Army è una serie di videogiochi sviluppata, finanziata e pubblicata dall’esercito degli Stati Uniti dal 2002 al 2022. Non era semplicemente ispirato all’esercito, ma era uno strumento esplicito dello stesso, ufficialmente definito come un “dispositivo di comunicazione strategica” progettato per “informare, educare e reclutare potenziali soldati”. In quanto tale, costituisce un chiaro caso di studio di un “advergame” prodotto dallo Stato e un potente strumento di propaganda.
Il design del gioco è stato meticolosamente studiato per servire al suo scopo ideologico:
- realismo edulcorato e inquadramento ideologico: America’s Army è stato caratterizzato per il suo presunto realismo, ma si trattava di una versione altamente selettiva ed edulcorata della guerra. Il gioco riproduceva meticolosamente i valori dell’esercito, il lavoro di squadra e le regole di ingaggio, ma ometteva sistematicamente le realtà strazianti del conflitto, come le vittime civili, i crimini di guerra e il trauma psicologico duraturo del combattimento. La morte era banalizzata, i giocatori semplicemente rinascevano. La struttura narrativa del gioco era progettata per essere politicamente “neutrale” in modo da rafforzare una specifica visione del mondo. I giocatori incarnavano sempre soldati americani, descritti come una squadra etnicamente diversificata e professionale. Il nemico, al contrario, era una “Forza avversaria” (OPFOR) astratta e disumanizzata, che impediva ai giocatori di identificarsi con un soldato americano virtuale o di sparargli. Lo scopo esplicito del gioco, come dichiarato nella sua pagina delle domande frequenti, era quello di “far sapere al mondo intero quanto è grande l’esercito degli Stati Uniti”.
- canale di reclutamento diretto: il gioco era molto più di una semplice pubblicità, ma era un sofisticato strumento di generazione di contatti. I dati dei giocatori venivano inviati direttamente alle stazioni di reclutamento dell’esercito americano. L’efficacia del gioco come strumento di reclutamento era significativa: uno studio del MIT del 2008 ha rilevato che il 30% degli americani di età compresa tra i 16 e i 24 anni affermava che il gioco aveva dato loro un’impressione più positiva dell’esercito, mentre altre ricerche militari indicavano che un’alta percentuale di arruolati aveva precedentemente giocato al gioco.
L’analisi accademica di America’s Army è quasi unanime nell’identificarlo come una forma di propaganda governativa. Gli studiosi sostengono che sia stato progettato per creare consenso nei confronti dei programmi militari, confondere i confini tra il campo di battaglia e il fronte interno e razionalizzare il coinvolgimento militare degli Stati Uniti all’estero presentando “un volto amichevole e ospitale dell’esercito”.
Caso studio: Call of Duty
Se America’s Army rappresenta il braccio produttivo dello Stato nel complesso militare-entertainment, la serie di videogiochi di Call of Duty ne rappresenta il braccio commerciale, immensamente redditizio. Sebbene non siano prodotti direttamente dal governo, questi giochi funzionano spesso come “pubblicità virtuali per la gloria presente e futura delle forze armate statunitensi”, perpetuando un insieme di ideologie simili attraverso il mezzo avvincente dell’intrattenimento.
Una decostruzione delle narrazioni e del design di questi giochi rivela diverse funzioni propagandistiche:
- narrative geopolitiche e revisionismo storico: le narrative della serie Modern Warfare, in particolare, riproducono spesso una geopolitica semplicistica, post-11 settembre, basata sulla contrapposizione tra “il bene e il male”. Il giocatore, che in genere incarna le forze speciali d’élite statunitensi o britanniche, si confronta con malvagi ultranazionalisti russi o terroristi mediorientali stereotipati. Ancora più preoccupante è la capacità della serie di revisionare la storia. Il reboot del 2019 di Modern Warfare è stato ampiamente criticato per una missione che raffigurava la famigerata “Autostrada della morte” - un evento in cui le forze statunitensi attaccarono i soldati iracheni in ritirata durante la guerra del Golfo del 1991, un atto condannato da alcuni come crimine di guerra - come un’atrocità commessa dalle forze russe. Ciò dimostra il profondo potere dei media interattivi di riscrivere la memoria storica al servizio di una narrativa politica contemporanea.
- il paradosso della “mela marcia”: nei casi in cui i personaggi americani sono antagonisti, come il generale Shepherd in Modern Warfare 2, vengono costantemente dipinti come traditori senza scrupoli o “mele marce”. Questo espediente narrativo è fondamentale poiché localizza il male all’interno di un individuo, proteggendo così l’istituzione militare stessa da qualsiasi forma di critica sistemica e rafforzando l’idea che il sistema stesso sia fondamentalmente buono.
- il “paradosso dell’autenticità”: una tensione centrale definisce il rapporto tra questi giochi e l’esercito. L’obiettivo dichiarato dagli sviluppatori, raggiunto grazie alla collaborazione con consulenti militari, è l’autenticità. Tuttavia, si tratta di un’estetica altamente selettiva. Il “realismo” di Call of Duty è incentrato sullo spettacolo viscerale del combattimento: il suono autentico delle armi, gli ambienti dettagliati e la ricostruzione delle tattiche militari. Ciò che viene sistematicamente escluso è la realtà della complessità legale e morale della guerra. I giochi raramente, se non mai, integrano le leggi del conflitto armato, la presenza di non combattenti o l’ambiguità morale dell’uccisione. Al contrario, promuovono attivamente il mito della “guerra come inferno”, una narrazione in cui le regole di ingaggio sono un ostacolo da superare nella ricerca della vittoria. Questo paradosso rivela la funzione fondamentale della collaborazione: la ricerca del “realismo” non è un obiettivo neutro, ma il veicolo principale della propaganda. Crea una realtà curata, eroica ed emozionante, molto più attraente della verità. Ciò è rafforzato dallo scudo retorico del “è solo un gioco”, che permette sia ai creatori che ai giocatori di distaccarsi dalle implicazioni politiche e morali del contenuto, creando uno spazio in cui il consenso viene fabbricato sotto le spoglie del gioco.
La propaganda invisibile
Giochi come Call of Duty e America’s Army funzionano come potenti strumenti di propaganda implicita:
- mostrano: armamenti scintillanti, tattiche eroiche, cameratismo.
- omettono: costi civili, traumi psicologici, ambiguità morale, conseguenze geopolitiche.
Il risultato è una visione della guerra sanificata, eccitante e priva di complessità, che plasma la percezione di un’intera generazione.
Sociologia e psicologia
Il consumo diffuso di videogiochi a tema militare ha importanti implicazioni psicologiche e sociologiche, che modellano gli atteggiamenti, i comportamenti e il discorso pubblico sui conflitti.
Dal punto di vista sociologico, l’esposizione costante a queste narrazioni può romanticizzare la guerra, normalizzare la violenza e promuovere i valori militari come norme sociali desiderabili.
Presentando l’intervento militare come una soluzione eroica e giustificabile a complessi problemi geopolitici, questi giochi possono influenzare l’opinione pubblica e favorire il sostegno a politiche estere aggressive.
Dal punto di vista psicologico, una delle principali preoccupazioni è il fenomeno della de-sensibilizzazione. L’esposizione costante alla violenza simulata può desensibilizzare i giocatori alle sue conseguenze nel mondo reale, confondendo i confini tra aggressività virtuale e reale. La natura immersiva di questi giochi, che premiano le azioni aggressive, può facilitare un impatto psicologico più profondo rispetto ai media passivi come la televisione.
Tuttavia, l’impatto non è monolitico. Un contrappunto cruciale è che i giocatori non sono semplicemente destinatari passivi di propaganda.
Alcuni studi indicano che i giocatori possono e vogliono impegnarsi criticamente con i contenuti dei giochi e che giocare a giochi militari non si traduce automaticamente in atteggiamenti militaristici. I giocatori possono essere più concentrati sugli aspetti ludici del gioco - la sfida, le tattiche, l’interazione sociale - che sui messaggi politici. Inoltre, alcuni giochi, anche all’interno di franchise mainstream, possono contenere missioni o momenti che provocano disagio, senso di colpa e riflessione morale nei giocatori, suggerendo una relazione più complessa e ambivalente tra il giocatore e il testo. In una contraddizione finale e sorprendente, mentre alcuni studi collegano il gioco alla salute mentale negativa, altri hanno scoperto che i videogiochi possono essere un potente strumento terapeutico per i veterani militari, fornendo un mezzo di connessione sociale, distrazione e recupero da condizioni come il disturbo da stress post-traumatico. Ciò evidenzia la natura profondamente personale e dipendente dal contesto dell’interazione di un giocatore con un gioco.
Un ciclo continuo e approfondimento
Sintetizzando il ciclo di relazioni:
- l’industria commerciale sviluppa tecnologie grafiche e di simulazione sempre più realistiche per intrattenere.
- l’apparato militare adotta queste tecnologie (come il motore grafico Unity, i cui accordi destabilizzarono la comunità degli sviluppatori alzando l’attenzione) per creare simulatori a basso costo e identifica nei giocatori un bacino di reclutamento con abilità pre-esistenti (riflessi, pensiero strategico).
- la cultura popolare, attraverso i giochi, assorbe e normalizza l’estetica, il gergo e la logica militare.
- i game designer, ispirati da concetti militari, creano nuove esperienze di gioco (come Root, il cui designer era un ex-analista della CIA), chiudendo il cerchio.
Se volete approfondire questa interconnessione, consiglio di guardare questo video del famoso canale YouTube People Make Games: “The Games Behind Your Government’s Next War”
Influence Warfare
Prima di introdurre il tema dell’Intelligenza Artificiale nei WarGames, dobbiamo parlare della Influence Warfare (guerra dell’influenza), una forma di conflitto non convenzionale che utilizza informazioni, propaganda, disinformazione, manipolazione psicologica e operazioni mediatiche per influenzare le percezioni, i comportamenti e le decisioni di individui, gruppi o popolazioni, al fine di ottenere un vantaggio strategico su un avversario senza ricorrere necessariamente alla violenza fisica.
Si colloca nell’ambito della guerra dell’informazione (Information Warfare) e si distingue per il focus sull’influenza cognitiva e sociale, spesso sfruttando piattaforme digitali, social media e narrazioni culturali.
L’obiettivo è modificare atteggiamenti, credenze o decisioni di un pubblico target (es. cittadini, leader politici, militari) per indebolire un avversario o rafforzare la propria posizione. Si tratta di una “battaglia per le menti” che mira a erodere legittimità, fiducia o coesione sociale.
Come mezzi usa la propaganda, fake news, campagne di disinformazione, operazioni psicologiche (PsyOps), manipolazione dei social media, e utilizzo di influencer o “orientatori” per diffondere narrazioni.
Può avvenire in tempo di pace o di guerra, in contesti di conflitto aperto o coperto, e coinvolge sia attori statali che non statali (es. gruppi terroristici, hacker).
Intelligenza Artificiale e Wargames
“L’IA non è neutra: dipende dalla missione che le affidiamo. In un gioco, può addestrare a uccidere o insegnare a negoziare.”
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando (anche) il game design (anche) nei giochi a tema bellico, permettendo di modellare conflitti futuri, testare scenari, e persino addestrare soldati attraverso simulazioni sempre più sofisticate.
Ci sono applicazioni militari, dove gli eserciti utilizzano l’IA per simulazioni strategiche. Programmi come il DARPA “Gamebreaker” o le simulazioni della Frazer-Nash Consultancy creano avversari intelligenti, capaci di apprendere e adattarsi alle mosse dei giocatori.
Nei nei giochi commerciali, come il già citato Call of Duty o Battlefield, IA avanzate permettono per comportamenti realistici dei nemici: copertura, accerchiamento, reazioni dinamiche. Queste tecniche contribuiscono a normalizzare la guerra, rendendola familiare e coinvolgente.
Giochi come Command: Modern Operations e Virtual Battlespace 4 vengono usati da analisti e militari per modellare scenari ipotetici, come un conflitto USA-Cina.
Game designer e specialisti di IA lavorano fianco a fianco con analisti militari, integrando tecniche di reinforcement learning[2] per creare ambienti dove gli NPC apprendono come veri soldati e generando scenari urbani complessi (es. droni, guerra asimmetrica), aumentando la validità operativa delle simulazioni.
Esercitazioni reali della Marina USA nel 2025 hanno impiegato interfacce simili a quelle videoludiche, con IA predittive per valutare esiti strategici.
Unsupervised Learning e il Pizza Index
Una delle caratteristiche innovative dell’Intelligenza Artificiale è la possibilità di analisi di grandi quantità di dati, anche i più diversi, e il trovare correlazioni che noi (umani) non vediamo immediatamente. Si chiama “unsupervised learning” e consiste appunto nel fornire uno scenario di dati, magari con una sua evoluzione temporale, e chiedere di trovare informazioni significative.
Un aneddoto simpatico correlato ai dati e alle previsioni di guerre, è quello del Pentagon Pizza Index: una curiosità storica che collega l’aumento delle ordinazioni di pizze vicino al Pentagono a momenti di crisi geopolitica, con radici negli anni '80 e conferme aneddotiche in eventi come la Guerra del Golfo. Sebbene non sia un indicatore scientifico, la sua popolarità, amplificata da social media e OSINT (Open-Source Intelligence), lo rende un fenomeno culturale che evidenzia come anche dati banali possano assumere significato in contesti complessi.
L’efficacia da dimostrare e Complessità
Nonostante il loro potenziale, i giochi di guerra sono strumenti non sono infallibili, anzi a volte hanno risultati opposti alle aspettative.
Ad esempio le simulazioni sull’offensiva ucraina del 2023 si sono rivelate imprecise. Lo scenario era troppo complesso e imprevedibile!
Sponsor militari possono influenzare inconsciamente le dinamiche simulate, perché iniettano o pagano per vedere quello che già conoscono e si aspettano
Se c’è una caratteristica universale delle operazioni di guerra è la segretezza, delle strategie e delle dotazioni militari, ad esempio. Spesso non vengono condivisi tutti i dettagli e i wargame militari sono raramente pubblici o verificabili.
Qui ci ricolleghiamo alle caratteristiche della Complessità vista nell’introduzione, che rende difficile prevedere gli esiti di conflitti a causa di:
- molteplicità di attori: Stati, gruppi non statali, media e individui interagiscono in modi imprevedibili
- dinamiche informative: nell’Influence Warfare, la diffusione di disinformazione attraverso social media crea effetti a cascata difficili da controllare
- fattori non lineari: un singolo evento, come un tweet virale o un’azione militare simbolica debitamente pubblicizzata (es. l’offensiva di Kursk del 2024 o l’attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas), può alterare percezioni globali o dinamiche geopolitiche
Al cinema
Nota bene: qui parliamo di industria videoludica, ma come più volte accennato quella cinematografica è ben più radicata e attiva e ne ha parlato l’amico Federico Greco nel libro “Cinema e potere - Leggere la propaganda nella storia del cinema di Hollywood”
Tre film che mi sento di consigliare sopratutto ai giovanissimi
- WarGames - Giochi di guerra (1983): un giovane hacker crede di giocare a un videogioco, ma in realtà avvia una simulazione militare reale che porta il mondo sull’orlo di una guerra nucleare reale. Celebre la frase finale del computer WOPR: “L’unica mossa vincente è… non giocare.”
- The Last Starfighter - Giochi stellari (1984): un videogioco arcade è in realtà uno strumento di reclutamento per trovare i migliori piloti stellari della galassia.
- Ender’s Game - Il Gioco di Ender (2013) romanzo e film su come i giochi e le simulazioni possano diventare strumenti di addestramento così realistici da annullare il confine con la realtà.
Giochi per la pace
«La strategia non è solo guerra: è anche protezione, cura, previsione, prevenzione. E quando un sistema insegna a salvare una vita invece che a toglierla, non è più un wargame, ma un gioco di pace.»
Se i giochi possono addestrare alla guerra, possono anche addestrare alla pace. Il movimento dei “Serious Games” sfrutta le stesse meccaniche per coltivare l’empatia, facilitare il dialogo, la cooperazione ed esplorare percorsi complessi verso la pace.
Mentre i giochi di guerra militari hanno una lunga storia, la progettazione deliberata di giochi per un cambiamento sociale positivo è un campo più recente, ma in rapida maturazione. Questo movimento ha sviluppato le proprie basi teoriche, il proprio sostegno istituzionale e i propri principi di progettazione, stabilendo una chiara alternativa all’uso dei giochi a fini propagandistici.
Giocare per l’impatto sociale positivo
CI sono giochi il cui obiettivo principale non è l’intrattenimento, ma piuttosto l’apprendimento, la pratica di un’abilità o la creazione di un impatto sociale. Questo genere comprende una vasta gamma di applicazioni, dall’educazione alla sostenibilità, dall’impegno civico e la risoluzione dei conflitti.
Negli anni si sono introdotte diverse nomenclature (serious games, applied games, impact games, educational games), ma per semplicità qui li definiamo giochi per l’impatto sociale (positivo). E’ bene soffermarsi a volte su questo “positivo” perché ci sono casi in cui il game design è usato per altri fini, ma non è questa la sede.
Fondamentale per la crescita e la legittimità di questo settore è l’organizzazione no profit Games for Change (G4C), fondata nel 2004 con la missione di sostenere e promuovere l’uso dei giochi e dei media immersivi per il bene sociale. Ha favorito la creazione di un ecosistema globale, in particolare attraverso il suo evento annuale Games for Change Festival, definito il “Sundance dei videogiochi”, che riunisce sviluppatori, educatori, ricercatori e responsabili politici per presentare lavori innovativi ed esplorare il futuro dei giochi a impatto sociale. Il festival si conclude con gli Awards che celebrano titoli meritevoli in categorie quali “Impatto più significativo”, “Miglior gioco didattico” e “Miglior esperienza XR per il cambiamento”.
Intorno a questo movimento sono nati altri eventi in tutto il mondo, come la conferenza CIVIS a Malaga o il The Power of Play che si terrà in ottobre a Pesaro.
Fondamenti teorici dei giochi per la pace
Questi giochi ribaltano la filosofia di progettazione dei giochi militari, in cui i giochi di guerra spesso utilizzano un realismo selettivo e spettacolare per glorificare il conflitto, sviluppando invece un realismo emotivo e sistemico per rivelarne il costo umano e la complessità. Utilizzano gli stessi strumenti fondamentali dell’immersione e dell’azione peer sviluppare altri fini:
- empatia e capacità di assumere prospettive diverse: consentendo al giocatore di assumere il ruolo di un’altra persona e di compiere scelte dal suo punto di vista, i giochi possono favorire una comprensione profonda e indiretta di esperienze di vita diverse. Ciò è particolarmente rilevante per la risoluzione dei conflitti, dove la capacità di comprendere il punto di vista dell’avversario è fondamentale. La ricerca ha dimostrato che i giochi progettati specificamente per suscitare empatia possono essere strumenti efficaci per ridurre i pregiudizi e incoraggiare comportamenti pro-sociali.
- contatto cooperativo nei mondi virtuali: pietra miliare della psicologia della pace, l’ipotesi del contatto di Gordon Allport sostiene che il contatto positivo e cooperativo tra membri di gruppi diversi può ridurre i pregiudizi tra i vari gruppi. I giochi online forniscono un ambiente potente, scalabile e sicuro per facilitare questo contatto, creando le condizioni ideali per un’interazione positiva: status uguale all’interno del mondo di gioco, obiettivi comuni che richiedono cooperazione e un contesto divertente e coinvolgente.
- progettazione etica per un impatto sociale: l’obiettivo non è indottrinare i giocatori con un punto di vista specifico, ma sviluppare la loro capacità di pensiero etico. Ciò implica diversi principi chiave:
- stabilire obiettivi di apprendimento chiari
- fornire ai giocatori scelte significative e un feedback sulle loro conseguenze
- incoraggiare i game designer a impegnarsi in un’auto-riflessione critica sui valori incorporati nel loro lavoro
- rispettare l’autonomia dei giocatori guidandoli attraverso un processo di riflessione morale, etica e sistemica
Anche le organizzazioni civili usano il wargaming per simulare la resilienza umanitaria, logistica di crisi, catastrofi naturali, pandemie, grazie alla capacità dei sistemi gioco di analizzare e prendere decisioni in situazione complesse, scenari imprevedibili, necessitanti collaborazioni di molti attori (giocatori) diversi, sviluppando modelli etici e predittivi.
Il dilemma del divertimento
Una sfida fondamentale in questo campo è il “dilemma del divertimento”: un gioco eccessivamente didattico o moralista non riuscirà a coinvolgere i giocatori.
Il caso del gioco PeaceMaker ne è un esempio: alcune analisi suggeriscono che una volta che un giocatore scopre una strategia ottimale e ripetibile, il gioco perde la sua sfida e il suo potere di incoraggiare un’ulteriore esplorazione delle complessità del conflitto. Ciò implica che i giochi di pace più efficaci sono quelli che resistono alle risposte facili e sostengono invece uno stato di lotta produttiva e riflessiva.
Il “divertimento” deve derivare dal confrontarsi con l’ambiguità e la complessità del problema stesso, non dal raggiungimento di una semplice vittoria.
Casi di studio
Premessa: qui presentiamo giusto qualche titolo, approfondimenti li potete trovare iscrivendovi alla newsletter 2042 o alla community. Una volta l’anno teniamo un corso specifico sulla progettazione e utilizzo di questo tipo di giochi.
This War of Mine - la prospettiva dei civili
Il videogioco (e gioco da tavolo) This War of Mine (2014) rappresenta una pietra miliare nel sottogenere dei “giochi militari incentrati sui civili”. Il gioco sovverte radicalmente le convenzioni dei giochi di guerra tradizionali, spostando la prospettiva del giocatore da quella di un soldato a quella di un gruppo di civili comuni che lottano per sopravvivere in una città assediata e devastata dalla guerra.
Le meccaniche di base del gioco ruotano attorno al ciclo giorno/notte. Durante il giorno, i giocatori gestiscono il loro rifugio, creano oggetti essenziali e si prendono cura dei bisogni fisici e psicologici dei sopravvissuti. Di notte, devono inviare un sopravvissuto a cercare risorse in luoghi pericolosi e semi-casuali. È durante queste spedizioni che entra in gioco il motore morale centrale del gioco dove giocatori si trovano spesso di fronte a scelte difficili: rubare medicine a una coppia di anziani per salvare uno dei propri compagni? Usare la violenza per sottrarre cibo ad altri sopravvissuti disperati? Queste decisioni hanno conseguenze tangibili, non solo sulla disponibilità delle risorse, ma anche sullo stato mentale dei personaggi, che possono diventare depressi, distrutti o violenti a seconda delle azioni che il giocatore li costringe a compiere. L’impatto principale del gioco è quello di generare una profonda empatia per le vittime civili della guerra, costringendo i giocatori a confrontarsi con il calcolo morale e il costo umano del conflitto.
Gaming for Peace - formare i pacificatori
Passando dalla sensibilizzazione allo sviluppo di competenze pratiche, il progetto Gaming for Peace (GAP) è un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea che mira a creare un gioco per formare personale addetto al mantenimento della pace. Il progetto ha individuato una lacuna critica nella formazione militare e di polizia tradizionale: lo sviluppo delle “soft skill” essenziali per operare in ambienti di missione complessi, multiculturali e altamente stressanti.
Il risultato è un gioco di ruolo in 2D progettato per essere uno strumento di formazione accessibile e standardizzato. I giocatori incarnano personaggi di diverso sesso, nazionalità e ruolo organizzativo (ad esempio, polizia, militari, civili) per sperimentare prospettive diverse. Il gioco consiste in moduli di apprendimento basati su scenari che si concentrano sullo sviluppo e la valutazione di competenze fondamentali quali la consapevolezza culturale, la sensibilità di genere, la comunicazione, la cooperazione e la gestione dello stress. Incorporando in un gioco interattivo un programma didattico derivato da interviste con esperti di mantenimento della pace, GAP mira a fornire un ambiente sicuro in cui il personale può esercitarsi e migliorare le competenze interpersonali fondamentali che spesso fanno la differenza tra il successo e il fallimento in un’operazione di pace.
PeaceMaker, Games for Peace e Peaceland
- PeaceMaker (2007): questa simulazione di governo a turni mette il giocatore nei panni del primo ministro israeliano o del presidente palestinese, con il compito di raggiungere una soluzione a due Stati. Il meccanismo del gioco consiste nel prendere decisioni politiche, sociali e militari e poi osservarne le conseguenze sull’opinione pubblica e sulle relazioni internazionali. Il suo obiettivo principale è educativo e mira a insegnare ai giocatori l’immensa complessità e l’interconnessione delle questioni coinvolte nel conflitto israelo-palestinese. Studi empirici che utilizzano il gioco hanno dimostrato che l’identità reale e le affiliazioni politiche di un giocatore possono essere correlate al suo successo nel gioco, rendendolo un prezioso strumento di ricerca per esplorare i fattori socio-psicologici che influenzano il processo decisionale nei conflitti.
- L’iniziativa israelo-palestinese Games for Peace fornisce un’applicazione reale e convincente di questa teoria. Il programma utilizza il popolare gioco commerciale Minecraft per mettere in contatto scolari ebrei e arabi. Inserendoli in squadre miste e assegnando loro sfide di costruzione collaborative, il gioco incoraggia la comunicazione e abbatte gli stereotipi in un modo che sarebbe difficile da ottenere nel mondo fisico.
- Peaceland: Choose Your Memory: Questo innovativo progetto di gioco di ruolo si concentra sulle conseguenze di un conflitto. Il giocatore, assumendo il ruolo di un giornalista in un paese post-bellico fittizio, compie scelte che determinano il modo in cui vengono costruiti la memoria e il racconto della guerra passata. L’obiettivo principale del gioco è aumentare l’empatia e promuovere una comprensione più profonda di come le storie che raccontiamo sul passato abbiano un impatto diretto sul potenziale di pace a lungo termine o su una ricaduta nella violenza. Offre ai giocatori la possibilità di influenzare i risultati sia su scala individuale che nazionale, rivelando le conseguenze involontarie delle loro scelte narrative alla fine del gioco.
Papers, Please e Bury Me, My Love
In Papers Please il giocatore veste i panni di un funzionario di frontiera di un immaginario stato autoritario dell’Europa orientale è incaricato di controllare i documenti di immigrati e visitatori, ed è interessante perché riflette le conseguenze di un conflitto (profughi, tensioni geopolitiche) e la complessità delle scelte in un sistema opprimente, dove ogni decisione ha ripercussioni imprevedibili, sotto la pressione della nazionale, mostrando come le narrazioni ufficiali influenzino il comportamento dei cittadini e del giocatore.
Bury Me, My Love è invece Ispirato alla crisi dei rifugiati siriani, e segue Nour, una donna siriana che fugge dalla guerra per raggiungere l’Europa, con cui comunichiamo tramite messaggi in stile WhatsApp, con 19 possibili scenari finali dai positivi (asilo in Europa) a tragici (morte o separazione). La narrazione tocca il ruolo delle informazioni (es. voci su rotte sicure o propaganda anti-rifugiati), mostrando come le percezioni influenzino le scelte di Nour che deve prendere decisioni in un sistema caotico (es. trafficanti, confini, pericoli).
Entrambi i giochi presentano sistemi complessi ed enfatizzano empatia e resilienza, mostrando il ruolo dell’influenza della propaganda e delle informazioni nelle decisioni umane.
L’evoluzione della fiducia: GIOCO INTERATTIVO
Ci sono dozzine di giochi e videogiochi interessanti ma questo è speciale:
- lo puoi giocare subito, online, gratuitamente.
- spiega le basi della teoria dei giochi e delle interazioni umane
- tratta il tema conclusivo di questa dissertazione: come sviluppare la fiducia?
Questo gioco riprende ed evolve il tema del Dilemma del Prigioniero[3] simulando le interazioni tra due giocatori che devono scegliere se cooperare (inserire una moneta in una macchina, dando 3 monete all’altro) o imbrogliare (non inserire nulla, sperando che l’altro cooperi). La cooperazione reciproca genera guadagni per entrambi, ma imbrogliare può dare un vantaggio a breve termine a scapito dell’altro.
La conclusione del gioco mostra che fiducia emerge quando le interazioni sono ripetute, i benefici della cooperazione sono chiari e gli errori sono minimi, con due lezioni chiave:
- la fiducia richiede interazioni frequenti e benefici reciproci
- gli errori di comunicazione possono distruggere la fiducia
- strategie egoistiche possono vincere nel breve termine ma sono le strategie “eque” a vincere nel lungo periodo e in contesti ripetuti
Pere giocare apri questa pagina: https://lvdt.github.io/trust/
Un quadro comparativo
Per sintetizzare questi casi di studio, la tabella seguente fornisce un confronto diretto tra gli obiettivi di progettazione, le meccaniche di base e le esperienze che i giochi militari e di pace discussi intendono offrire ai giocatori.
| Titolo del gioco | Obiettivo principale | Meccaniche di base | Esperienza prevista per il giocatore |
|---|---|---|---|
| Call of Duty | Intrattenimento, spettacolo, profitto | Sparatutto in prima persona, combattimenti frenetici, narrazione lineare, rapporto uccisioni/morti | Fantasia di potere, eccitazione, eroismo, adrenalina |
| America’s Army | Reclutamento, pubbliche relazioni, indottrinamento | Sparatorie tattiche, lavoro di squadra, rispetto delle regole, obiettivi di missione | “Realismo” edulcorato, disciplina, coesione di squadra, patriottismo |
| This War of Mine | Empatia, consapevolezza delle sofferenze dei civili | Gestione delle risorse, sopravvivenza, scelte morali, furtività, creazione | Stress, angoscia morale, vulnerabilità, empatia, disperazione |
| PeaceMaker | Educazione, assunzione di prospettive diverse | Simulazione politica, processo decisionale a turni, gestione delle conseguenze | Comprensione della complessità, frustrazione, pensiero strategico |
| Gaming for Peace | Formazione delle competenze (soft skill per operatori di pace) | Gioco di ruolo, scelte dialogiche, apprendimento basato su scenari, valutazione delle competenze | Sviluppo delle competenze, autoriflessione, consapevolezza culturale |
| Peaceland | Empatia, comprensione delle dinamiche post-conflitto | Gioco di ruolo, scelta narrativa, esplorazione delle conseguenze | Empatia, riflessione critica sulla memoria e la narrativa |
| Papers, Please | Riflessione morale, critica dei sistemi autoritari | Simulazione burocratica, controllo documenti, scelte morali, gestione risorse limitate | Tensione, dilemmi etici, oppressione, riflessione su potere e responsabilità |
| Bury Me, My Love | Empatia, consapevolezza della crisi dei rifugiati | Avventura testuale, scelte narrative, comunicazione in stile messaggistica, finali multipli | Empatia, ansia, connessione emotiva, riflessione su guerra e migrazione |
| The Evolution of Trust | Educazione sulla fiducia e cooperazione | Simulazione interattiva, teoria dei giochi, scelte cooperative/competitive, tornei strategici | Comprensione della fiducia, riflessione strategica, consapevolezza sociale |
Il futuro dei conflitti nel gioco
L’uso dei giochi per modellare i conflitti è in evoluzione, spinto dai progressi tecnologici e dal crescente riconoscimento della loro utilità in campi che vanno oltre l’addestramento militare. Il futuro punta verso un mondo in cui i giochi saranno sempre più integrati nelle politiche di alto livello, nella diplomazia e persino nell’analisi predittiva, sia per condurre la guerra che per prevenirla.
L’evoluzione dei giochi di guerra
Il wargaming professionale si sta espandendo ben oltre le sue tradizionali applicazioni militari. I politologi e gli studiosi di relazioni internazionali utilizzano sempre più spesso i giochi di guerra come metodo di ricerca per studiare il processo decisionale in eventi rari o ad alto rischio, dove i dati reali sono scarsi. I governi e i think tank utilizzano ora i giochi di guerra per simulare ed esplorare le risposte a una vasta gamma di sfide alla sicurezza nazionale, tra cui la guerra nella “zona grigia”, le crisi economiche, i disastri naturali e i negoziati diplomatici. Inoltre, con l’espansione dei domini di conflitto, il wargaming viene adattato per esplorare i futuri scontri nello spazio e nel cyberspazio, aiutando i responsabili politici a comprendere le vulnerabilità uniche e le dinamiche strategiche di queste nuove frontiere. Questi “sandbox cognitivi” consentono ai leader di testare strategie e sperimentare le conseguenze delle loro decisioni in un ambiente sicuro, affinando il loro giudizio per le crisi del mondo reale.
Costruzione predittiva della pace
Dall’altra parte della medaglia, il campo dei giochi di pace si sta muovendo verso un futuro di “costruzione predittiva della pace”. Ciò comporta l’integrazione di intelligenza artificiale, machine learning e analisi dei big data per creare modelli sofisticati in grado di prevedere i punti caldi dei conflitti e identificare le opportunità di intervento proattivo.
I principi della Teoria dei giochi, che forniscono un quadro matematico per l’analisi delle interazioni strategiche, vengono utilizzati per modellare negoziazioni complesse su questioni come il cambiamento climatico e il commercio internazionale, contribuendo a identificare percorsi di cooperazione.
Concetti emergenti come il “Peace Data Standard”[4] propongono un quadro di riferimento per l’utilizzo dei big data al fine di misurare e facilitare sistematicamente i comportamenti positivi tra i gruppi. Analizzando i modelli di comunicazione e cooperazione tra le piattaforme digitali, questo approccio mira a identificare le condizioni che favoriscono la pace e a scalare efficacemente tali interventi.
Nel prossimo futuro, i modelli informatici potrebbero essere in grado di mappare i potenziali risultati delle strategie diplomatiche, mentre a lungo termine questi strumenti potrebbero diventare essenziali per gestire i conflitti esacerbati da sfide globali come il cambiamento climatico.
Il paradosso del martello
Un designer disse:
“Un wargame è come un martello: puoi usarlo per costruire o per colpire.”
Ma se lo progetti per colpire, puoi davvero declinare la responsabilità? Questo resta il dilemma centrale del design ludico in contesto bellico.
«Se il gioco ci aiuta a capire cosa siamo disposti a fare per vincere, può anche chiederci cosa siamo disposti a non fare per restare umani?»
Filosofie progettuali
La distinzione tra un “gioco di guerra” e un “gioco di pace” non è solo una questione di contenuto, ma di filosofia progettuale fondamentale, responsabilità etica e impatto psicologico desiderato.
L’industria dei giochi, che sia commerciale o “seria”, detiene un potere immenso. Non è più un semplice passatempo, ma un motore culturale, tecnologico e persino politico. Ignorare la sua crescente simbiosi con gli apparati militari significa abdicare a una responsabilità.
Come giocatori, sviluppatori, accademici e cittadini, abbiamo il dovere di promuovere una maggiore alfabetizzazione mediatica. Dobbiamo imparare a riconoscere quando un gioco ci sta vendendo una fantasia di potere e quando ci sta chiedendo di affrontare una complessa verità. Dobbiamo esigere trasparenza e sostenere attivamente i progetti che utilizzano il potere del gioco non per addestrare soldati migliori, ma per costruire esseri umani più empatici.
L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di coltivare una comprensione culturale più ampia di come i giochi funzionano come sistemi e di come influenzano il nostro modo di pensare. Imparando a leggere e comprendere le regole, le meccaniche e le narrazioni dei giochi a cui giochiamo, diventiamo consumatori di media più consapevoli e cittadini più capaci. Che un gioco sia un’arma o uno strumento di comprensione dipende da chi lo crea, da chi ci gioca e dalle domande che siamo disposti a porci.
Il Game Designer è politico
I giochi di intrattenimento a tema militare, in particolare quelli appartenenti al complesso militare-entertainment, tendono a presentare un mondo definito da conflitti a somma zero, dove la violenza è il mezzo principale, e spesso l’unico, per risolvere i problemi, e il successo si misura con la sconfitta di un nemico chiaramente definito.
I giochi di pace sono quasi universalmente progettati intorno a problemi non a somma zero. Essi modellano situazioni in cui l’aggressione unilaterale porta a risultati reciprocamente negativi e in cui il successo richiede comunicazione, cooperazione, empatia e la ricerca creativa di soluzioni reciprocamente vantaggiose.
Entrambi i generi, tuttavia, necessariamente astraggono la realtà:
- i giochi di guerra astraggono il costo umano, l’ambiguità morale e i vincoli legali del conflitto per creare uno spettacolo pulito ed eroico.
- i giochi di pace, al contrario, devono astrarre sistemi sociali, politici ed economici incredibilmente complessi in un formato giocabile.
Questo atto condiviso di astrazione sottolinea l’immensa responsabilità etica del progettista del gioco. Tutta la progettazione dei giochi è intrinsecamente politica, poiché la scelta di cosa includere, cosa escludere e quali azioni premiare modella la comprensione del giocatore del sistema modellato.
In definitiva, l’impatto di questi giochi su un giocatore può essere meno legato all’indottrinamento diretto e più alla coltivazione di una particolare esperienza affettiva e di una “sensibilità per il gioco” della realtà sociale.
Sebbene gli studi sulla ricezione da parte dei giocatori mostrino un quadro complesso, con alcuni giocatori che resistono criticamente al messaggio inteso dal gioco, il coinvolgimento ripetuto con un particolare sistema di gioco può normalizzarne la logica sottostante.
Raccomandazioni finali
Sulla base di questa analisi completa, si propongono le seguenti raccomandazioni:
Per educatori e genitori è fondamentale promuovere un alto livello di media education in materia di giochi. I giochi a tema militare non dovrebbero essere necessariamente vietati, ma piuttosto utilizzati come testi critici per analizzare la propaganda, il revisionismo storico e la romanticizzazione della violenza. Al contrario, giochi pacifisti dovrebbero essere attivamente integrati nei programmi scolastici per insegnare l’empatia, il pensiero critico, il pensiero sistemico e le capacità di risoluzione dei conflitti.
Per gli sviluppatori ed editori l’industria deve adottare un maggiore senso di responsabilità etica. I progettisti dovrebbero riflettere consapevolmente sui valori politici e sociali insiti nelle loro meccaniche e narrazioni. Esiste un mercato significativo e in crescita per i giochi che offrono qualcosa di più di una fantasia di potere, e gli sviluppatori dovrebbero essere incoraggiati a creare giochi coinvolgenti e commercialmente validi che stimolino i giocatori a pensare in modo critico e a riflettere su questioni sociali complesse.
Riferimenti
Bibliografia
- Clausewitz, Carl von. Della Guerra (Vom Kriege). Un’opera fondamentale della strategia militare, pubblicata per la prima volta nel 1832, in cui viene articolato il celebre concetto della guerra come “continuazione della politica con altri mezzi”.
- Downes-Martin, Stephen. “The Three Witches of Wargaming.” Naval War College Review, 2013. Un saggio che analizza i tre principali tipi di bias (dello sponsor, della catena di comando e dei giocatori) che possono compromettere la validità di una simulazione.
- Ministry of Defence (UK). Influence Wargaming Handbook. Development, Concepts and Doctrine Centre, 2018. Il manuale ufficiale del Ministero della Difesa britannico che introduce i concetti e le metodologie per simulare la “influence warfare”, ovvero il conflitto combattuto nel dominio dell’informazione e della percezione. Link al pdf
Articoli
- Dilemma del Prigioniero (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
- Introduzione ai Matrix Games (The Wargaming Society Un tipo di wargame simile a un gioco di ruolo, in cui i giocatori propongono azioni e argomentazioni, e il successo è determinato da un moderatore, spesso usato per simulare situazioni complesse.
- The Washington Post - "Secret war plan, leaked documents show, predicted Ukraine’s stalled offensive. 2023. L’articolo che ha analizzato le discrepanze tra le previsioni dei wargame statunitensi e i risultati reali dell’offensiva ucraina, sollevando dubbi sull’efficacia di tali simulazioni.
Video
- People Make Games. “Governments Are Paying Millions To Resurrect Wargaming.” YouTube, 2024. Il video-saggio che analizza la rinascita del wargaming e il suo rapporto con l’industria dei videogiochi.
Guarda il video su YouTube - WarGames - Giochi di guerra (1983). Scheda del film su IMDb
- Giochi stellari (The Last Starfighter) (1984). Scheda del film su IMDb
Videogiochi e giochi da tavolo
- America’s Army: Il videogioco sviluppato e pubblicato dall’esercito degli Stati Uniti a partire dal 2002 come strumento di pubbliche relazioni e reclutamento. Steam
- Call of Duty: Una delle serie di videogiochi di maggior successo commerciale, spesso citata come esempio di rappresentazione spettacolare e sanificata del conflitto militare.
Sito Ufficiale di Call of Duty - Kriegsspiel: Il wargame originale sviluppato in Prussia all’inizio del XIX secolo, considerato l’antenato di tutte le moderne simulazioni di guerra e dei giochi di strategia.
Approfondimento sul Kriegsspiel (The Wargamers) - PeaceMaker: Un “serious game” che mette i giocatori nei panni dei leader israeliani o palestinesi, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione pacifica.
Sito Ufficiale di PeaceMaker - Root: A Game of Woodland Might and Right: Un gioco da tavolo strategico di Cole Wehrle, le cui meccaniche di contro-insurrezione sono state ispirate dal lavoro del designer Volko Ruhnke (ex-analista CIA) per i suoi wargame professionali.
Pagina del gioco su Leder Games - This War of Mine: Un videogioco di sopravvivenza che inverte la prospettiva bellica, concentrandosi sulle difficoltà e i dilemmi morali dei civili intrappolati in una città assediata.
Sito Ufficiale di This War of Mine
Organizzazioni e conferenze
- Games for Change: www.gamesforchange.org
- Connections Wargaming Conference: La principale conferenza professionale per la comunità del wargaming (militare, accademico e commerciale) nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Sito Ufficiale di Connections UK - Defence Science and Technology Laboratory (Dstl): L’agenzia esecutiva del Ministero della Difesa del Regno Unito, responsabile della ricerca e sviluppo in campo scientifico e tecnologico per la difesa e la sicurezza, inclusa l’area del wargaming.
Sito Ufficiale del Dstl - Gaming for Peace (GAP): Un progetto finanziato dall’Unione Europea (tramite il programma Horizon 2020) per sviluppare un videogioco di ruolo destinato all’addestramento del personale impegnato in missioni di peacekeeping.
Sito Ufficiale del Progetto GAP - Serious Games Initiative: Un’iniziativa nata per promuovere l’uso dei giochi in settori diversi dall’intrattenimento, come l’istruzione, la sanità, la politica e la difesa.
Archivio della Serious Games Initiative (Wilson Center) - Watch the Skies: Un “megagame” (gioco su larga scala con decine di giocatori) a tema invasione aliena, creato da professionisti del wargaming britannico e reso popolare dal canale YouTube “Shut Up & Sit Down”.
Comunità dei Megagame Makers
un celebre gioco da tavolo sulla Guerra Fredda è “Twilight Struggle” ↩︎
Un’introduzione ai meccanismi di AI generativa e Machine Learning la scrissi tempo fa qui: Gli androidi sanno disegnare una pecora? ↩︎
sviluppato da Nicky Case nel 2017, basato sulla teoria dei giochi e ispirato al libro The Evolution of Cooperation di Robert Axelrod (1984). ↩︎
vedi Peace Data Standard ↩︎